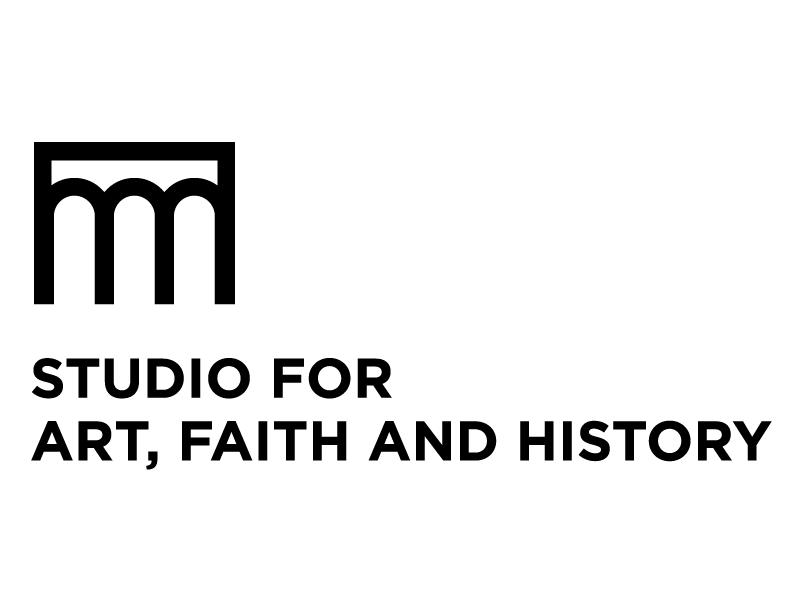I Novissimi (Morte, Giudizio, Inferno e Paradiso):
parte “difficile” della doctrina christiana
carlo manunza (2022)
S.J. docente di esegesi e teologia biblica
presso la Sezione S. Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, Napoli
Morte, giudizio, inferno e paradiso. Sono termini che a noi suonano quantomeno noti, e che incutono da subito una vena di preoccupazione e d’inquietudine. È una parte della dottrina cristiana della quale non è facile parlare oggi, anche se evoca, appunto con inquietudine, qualcosa di generalmente noto, per sommi capi, nei suoi contenuti, e, almeno per quanto riguarda la morte, indiscutibilmente legato alla nostra condizione umana.
In queste poche pagine non vogliamo descrivere il contenuto di queste quattro parole secondo la dottrina della Chiesa, cosa che riteniamo superflua visto che i termini sono noti e che i loro contenuti sono descritti in poche pagine con buona nitidezza nel Catechismo della Chiesa Cattolica (Catechismo della Chiesa Cattolica, Roma 1993, Parte I, Sez. II, cap. III, art. 12 [NN. 1020-1050]). Preferiamo fornire a chi ci legge alcune coordinate di fondo che aiutino ad entrare in sintonia con Luca Signorelli che ha dipinto gli affreschi della Cappella di San Brizio, con chi glieli ha commissionati e con chi insieme a lui li ha realizzati, e con la schiera di persone che ne hanno goduto fino ad oggi.
Un tema iconografico tradizionale...ma a Orvieto innovativo
Com’è stato osservato, la richiesta di affrescare una cappella interamente con i temi dei Novissimi fu a suo tempo abbastanza originale. Il programma tradizionale di pittura delle chiese suggeriva, a lungo nei secoli che han preceduto il Quattrocento, che il giudizio universale occupasse la retrofacciata dell’edificio templare cristiano: era l’immagine che il fedele vedeva per ultima quando usciva dal tempio. Il giudizio, sviluppato in dimensione verticale (in basso i dannati, in alto i beati e poi Dio) secondo una spazialità simbolica biblica e neotestamentaria, ricordava al fedele il potere delle opere della vita ordinaria, nella quale egli rientrava una volta terminato il tempo di preghiera.
Il programma architettonico tradizionale affonda le sue radici nella prassi catechetica dei Vangeli Sinottici, che terminano la loro grande catechesi, prima del racconto della passione del Signore, con il discorso sugli ultimi tempi: Matteo esplicitamente racconta il giudizio alla fine dei tempi (Mt 25), Luca (Lc 21) e Marco (Mc 13) riportano entrambi un discorso sul futuro e sulla fine dei tempi. Come scrive esplicitamente Luca concludendo il Cap. 21, la trattazione di questi temi ha per fine l’esortazione a vigilare, a far sì che il destinatario, o meglio i destinatari della catechesi evangelica restino con un atteggiamento di desta attenzione, e si comportino perciò in modo che tenga conto delle verità ultime che hanno appena ascoltato.
Il discorso sugli ultimi tempi: una “tradizione” che ha le sue radici nei vangeli
Il senso di disagio e d’inquietudine che questi discorsi suscitano immediatamente al solo affiorare alla nostra coscienza possono essere porta a diversi atteggiamenti e rapporti che chi lo vive instaura con chi li propone o li impone all’attenzione. Al disagio può seguire, per esempio, una distanza, che diviene facilmente disinteresse o rifiuto di entrare in empatia rifugiandosi in incredulità, o in sufficienza che diventa facilmente derisione o cinismo. Ma nella dottrina cristiana l’obiettivo di chi entra in questi temi è certo un altro: non è infatti un caso che essi vengano trattati alla fine della catechesi evangelica, quando cioè il rapporto fra chi ha scritto (e chi leggeva a voce alta) il testo e chi lo ascolta ha già fatto un percorso, stringendosi e approfondendosi nel tempo. Se poi teniamo conto che le memorie degli apostoli (così le chiama S. Giustino, al quale dobbiamo la prima descrizione di una liturgia domenicale cristiana) erano state messe per iscritto per essere lette insieme e a voce alta in un’assemblea radunatasi nel giorno del Signore per pregare, per stare in contatto con Cristo Risorto, ci viene facile intuire che il Vangelo, quando tratta questi temi, suppone una confidenza e una fiducia con i suoi destinatari ormai forti e costituite, tali da permettere di toccare argomenti “gravi” o comunque “forti” senza reazioni di disinteresse o di fuga, facili e legittime dove si volesse imporre contenuti propri di un rapporto “forte” senza che questo abbia avuto tempo, occasione e modo di stabilirsi.
Parlare infatti della morte, il primo dei Novissimi, non è certo argomento né facile, né leggero né piacevole. Lo rileviamo anche dalla nostra cappella, che pure nel primo dei quadri dipinge diversi assassinii: pur parlando dei Novissimi, la morte in sé non è dipinta: è dipinto invece il tempo dell’anticristo. Per poter parlare di queste cose, della morte in primo luogo (e di ciò che dal parlarne discende come conseguenza per la vita ordinaria dell’oggi), c’è bisogno di una disponibilità da parte di chi ascolta. Per quanto sia vero e noto che tutti gli uomini devono morire, non per questo si è disposti normalmente a parlare o sentirne parlare come cosa che ci riguarda. C’è bisogno di creare una disponibilità da parte di chi ascolta: non sono “discorsi di vita ordinaria”.
Ultimi tempi e apocalittica
Sia la Bibbia ebraica sia il Nuovo Testamento, pur consapevoli della difficoltà che abbiamo appena detto, non rinunciano a parlarne. Il modo in cui ne parlano, affiora da quanto fanno i vangeli, si serve del linguaggio cosiddetto “apocalittico”. Questo termine, “apocalittico”, deriva da “apocalisse”, parola con cui si apre e che ha pertanto dato il titolo all’ultimo libro della Bibbia cristiana, l’Apocalisse di Giovanni (Ap 1,1). Il termine apokalypsis in greco significa “rivelazione”, quindi qualcosa che di per sé non parla né di ultimi tempi, né di fine del mondo, ma indica semplicemente l’azione di svelare qualcosa che era velato (così il verbo apoklaypto). Di fatto il libro di Giovanni due volte, all’inizio (1,1) e alla fine (22,6) dice di mostrare (o di aver mostrato) “ciò che deve accadere presto”, anche se ciò non significa né fine dei tempi né tantomeno quel che avverrà dopo la fine dei tempi. Parte della predicazione e della presentazione successiva ha legato il linguaggio ai tempi ultimi (cosiddetti “escatologici”, da eschaton greco, che significa “ultimo”), tanto che oggi nel linguaggio comune, anche cinematografico, parlare di “apocalisse” è parlare di catastrofi di grandi proporzioni, tali da determinare o da minacciare la fine della vita e del tempo di vita di chi vi sta in mezzo. In Ap troviamo anche il riferimento a “cieli e terra nuovi” (21,1), e alla certezza che alla fine il male e la morte saranno annientati (20,10.14), come anche ad un giudizio (20,12). Ma, come abbiamo visto per i vangeli sinottici, Giovanni parla di questi temi verso la fine del libro, che conta in tutto 22 capitoli. Ne parla cioè solo quando chi lo ascolta in assemblea ( 1,3) ha già avuto tempo di instaurare con lui un rapporto di fiducia e confidenza che gli permette di parlare della morte di tutti, compresa di quella di chi lo ascolta.
Un discorso rivolto ai vivi
Queste poche elementari considerazioni rivelano subito una cosa ovvia eppure per noi molto importante, ripetuta da ultimo anche dal papa Bendetto XVI (Spe salvi, n.12) proprio parlando di questi temi. Quando parliamo di “fine dei tempi” e di quel che avverrà allora, non bisogna mai scordare che ne parliamo “da vivi” e “a vivi”: sia chi scriveva sia chi legge come chi ascolta è vivo, è dentro il tempo, e non ne può uscire. È dunque un errore pensare che i racconti su quel che “avverrà alla fine dei tempi” sia come una telecamera il cui obiettivo, rivolto sulla fine dei tempi e sul suo dopo, ci mostri “in anticipo” come continua il tempo dopo che è finito! Se siamo vivi, quest’operazione è impossibile: non possiamo pensare e vivere “da morti”. Lo scopo principale del linguaggio apocalittico, linguaggio che usa immagini ed espressioni “forti”, ad alto impatto emotivo, più che trasmettere informazioni è invece quello di coinvolgere l’ascoltatore (o il lettore) con tutta la sua persona, iniziando dai suoi sentimenti, che le immagini e i temi “forti” suscitano. In questo modo chi ha scritto i libri della Bibbia, soprattutto le parti “escatologiche” del Nuovo Testamento, cerca di dire l’indicibile: dove la ragione fa fatica ad avventurarsi con la sua logica, ecco che i sentimenti e l’affettività vengono invocati per entrare in un campo altrimenti inaccessibile.
La “riscoperta” della voce
Dal secolo scorso si è “riscoperto” che l’”apocalittica” è in realtà theo-logia, in greco letteralmente “discorso (o anche “pensiero”) su Dio”, cioè modo e linguaggio per parlare di Dio, trascendente e quindi indicibile, misterioso. Paradossalmente, è un modo per “parlare di ciò di cui non si può parlare”, cioè per pensare con il nostro pensiero, finito, ciò che è infinito: Dio, la sua divinità e la sua trascendenza, il cielo. Tuttavia, non si tratta solamente di linguaggio (o meglio di genere letterario, cioè di modo di parlare), e ancora meno di sole idee o pensiero. Nella comunicazione che instaurano i testi apocalittici, hanno un’importanza essenziale il rapporto fra chi legge, chi ascolta e chi scrive, e gli atteggiamenti con cui tutte queste persone comunicano fra loro: sono importanti come o più delle informazioni e dei pensieri o concetti che le parole offrono o degli affetti e i sentimenti che esse suscitano.
Bisogna infatti tener conto del dato, noto ma “strano” e spesso ignorato da noi moderni, che gli scritti dell’inizio dell’era cristiana erano destinati non tanto alla lettura silenziosa e solitaria, come oggi normalmente viene fatto per i libri, ma alla lettura pubblica e a voce alta. Erano cioè composti non tanto per essere letti, ma per essere ascoltati in gruppo. Questo cambia le cose molto più di quanto sembri a prima vista. Non è la stessa cosa, per esempio, leggere un’opera teatrale da soli o vederla rappresentata a teatro. O, ancora più chiaramente, non è lo stesso leggere l’”inno alla gioia” della IX sinfonia di Beethoven da un libro o da uno spartito musicale, oppure sentirlo, ad un concerto, cantato da un coro accompagnato da un’orchestra: sono due esperienze ben diverse, sia quanto a coinvolgimento, sia quanto a rapporto con chi ha composto e chi canta o suona, sia quanto a contenuti e impatto che si riceve dentro di sé.
Tenere conto di ciò ritorna a colorare della sua luce originaria il “discorso” sugli ultimi tempi e sui Novissimi. Diviene allora ben diverso il tentativo di trasmettere l’indicibile, laddove si sia insieme e si metta direttamente in gioco non solo la vista (come fa il lettore silenzioso e solitario), ma quantomeno anche l’udito e il respiro (la voce è suono, emesso dall’aria che attraversa i polmoni e le corde vocali di chi parla, legge in pubblico o canta e le orecchie di chi ascolta) . Il coinvolgimento di tutta la persona, al quale le immagini “forti” e gli argomenti impegnativi trattati mirano, grazie all’oralità e alla comunità è qualcosa di molto più effettivo, concreto, “corporeo”, com’è diverso sentir parlare della persona amata e invece vederla in fotografia o stringere fra le mani un suo regalo!
Apocalisse e liturgia di un Dio che si è fatto uomo fra gli uomini
Ci sono molti modi di comunicare e di entrare in rapporto con gli altri, e anche molti modi di coinvolgersi in questi rapporti. Un ascolto fatto insieme di scritti che si ritengono parola di Dio all’inizio dell’era cristiana fa pensare alla liturgia. I cristiani fin dall’inizio si riunivano regolarmente per celebrare il culto e per pregare. Il coinvolgimento e l’ascolto appena visto divengono allora un modo di vivere la preghiera e il contatto con Dio, il culto. Ciò indica un modo particolare di coinvolgimento: ciò che riguarda l’apocalittica e gli ultimi tempi intende allora comunicare non solo emozioni; attraverso immagini, parole, “discorsi” letti e ascoltati ad alta voce intende rendere sensibile un contatto con il mistero, cioè “immergere” nel mistero coloro i quali ascoltano e condividono il culto che si celebra attraverso la lettura. Non si tratta però solo di un coinvolgimento da spettatori, cioè di assistere semplicemente a uno spettacolo come si fa a teatro o ad un concerto. Il contatto con un Dio che si è fatto uomo non è il contatto con un qualsiasi uomo, “che non può salvare”. È invece porta all’infinto, è ingresso in cielo per un momento, quello del culto, perché il cielo possa entrare nel resto della vita, trasformando la persona che vi entra. Scrive S. Giovanni nella sua prima lettera, indicando il contatto con Dio come comunione: «quello che abbiamo veduto e udito, lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena.» (1Gv 1,3-4). Scritti come gli altri testi cristiani per la celebrazione del culto, i testi apocalittici antichi e i loro autori volevano non solo dare informazioni o predire il futuro, né far assistere a uno spettacolo o a una declamazione: volevano, ben oltre, condividere sensibilmente la comunione con Dio fattosi uomo di cui parla S. Giovanni, facendovi entrare effettivamente e con tutta la persona (sensi inclusi, a iniziare dall’udito) anche gli ascoltatori. La liturgia cristiana si celebrava settimanalmente la domenica; abbastanza presto iniziò a ripetersi ogni anno seguendo un ciclo annuale di feste, come avviene ancora oggi: la celebrazione della Pasqua (cui si unì poi quella di Natale) scandiva lo scorrere della vita dell’anno, come la domenica scandiva la vita della settimana. Il ripetersi del culto segnava, nel progredire del tempo, il rinnovarsi e il progredire dell’ingresso nel mistero, nel contatto con Dio. Il rapporto con Dio, sensibile nel culto, era così chiamato a trasformare e a irradiarsi sempre di più in tutta la vita, inclusa quella ordinaria, come avviene in qualsiasi rapporto umano, per esempio l’amicizia, che cresce e si rafforza attraverso la frequentazione.
Discorso degli ultimi tempi e vita presente
Alla luce di questa prospettiva, possiamo adesso approfondire il tema specifico che Signorelli dipinge nella nostra cappella. Il parlare di resurrezione della carne, inferno e paradiso dà per scontata la morte. Abbiamo già accennato all’effetto immediato che questa fa su chi oggi ne sente parlare come cosa che può toccarlo e che in futuro prima o poi lo riguarderà: il disagio. Questo impatto è comune alle persone di oggi come a quelle dei primi secoli dell’era cristiana e del Quattrocento.
Per parlare di giudizio, che si frappone fra la resurrezione della carne e l’inferno e paradiso, le cose stanno diversamente. C’è un principio base da tenere presente per entrare in comunicazione, oggi, con chi parla di o dipinge il giudizio ultimo al tempo del Nuovo Testamento, e, vedremo, in una certa misura anche nel Quattrocento. Bisogna dimenticare, prima di tutto, ciò che una persona moderna normalmente e come prima cosa ha in mente quando sente la parlare di “giudizio di un giudice”. Per noi suona, in questo contesto, l’atto finale con cui un giudice decide e dichiara che cosa tutti debbano tenere come verità di un fatto, cioè la sentenza, con le sue conseguenze “pratiche” di assoluzione o di condanna cui l’accusato e chi ha rapporti umani con lui dovrà sottostare. La sentenza vale come verità, decide come stanno per tutti le cose. Si suppone che ciò corrisponda alla verità dei fatti, ma ciò che importa ormai è la sentenza, ciò che ha deciso il giudice, non più gli eventi, la storia. In un certo senso, il giudice ha il “potere” di creare la “verità”, o meglio gli effetti che dalla storia dovrebbero e devono discendere.
Il principio base e quindi il significato cui “giudizio” fa riferimento nel mondo dell’apocalittica è un altro. Nasce da una constatazione facile e immediata: la verità della persona dipende da quello che fa. Per esempio, se uno ruba, è un ladro; se uno uccide, è un assassino; se uno tradisce (un amico, il coniuge, chi si fida di lui) è un traditore; etc. Ciò che l’uomo fa, decide e determina quel che egli è. Anche se l’uomo “nasconde” a un numero più o meno grande di persone quel che ha fatto, la sua storia comunque lo segna, a volte in modo indelebile. Basta solo pensare al “marchio” che imprime su una persona e sui suoi rapporti sociali l’essere stato in carcere: assai difficilmente un datore di lavoro, potendo scegliere fra diversi candidati ad un ufficio, tratterà allo stesso modo nella sua scelta chi è stato in carcere (ed anche chi è figlio di carcerati) e chi non lo è; il “buonsenso” impone di preferire chi è incensurato, per ovvie ragioni, non foss’altro per prudenza. Se invece tratta i due allo stesso modo, lo fa solo per bontà, per amore. Iniziamo così a vedere che alcune azioni e le loro conseguenze operative hanno un effetto sulla persona, che non si limita solo alla superficie, solo a “quel che si vede subito”. Hanno una profondità, che ha e potrà avere conseguenze ben operative sulla sua vita e sui suoi rapporti con gli altri, e che non “si vede subito” e non si riduce all’effetto materiale immediato che l’azione produce. Per chi viveva al tempo in cui sono stati composti i testi apocalittici cristiani o i relativi discorsi sulla fine dei tempi, “giudizio” allora non è “creare una verità”, ma ripetere, dichiarare, portare alla luce la verità della persona. Non tanto la verità degli eventi o delle sue azioni, ma la verità ultima, profonda, che queste azioni hanno determinato, generato.
Il linguaggio apocalittico vuole aiutare a vedere questa verità della persona, che le sue azioni portano con sé. Parlare di giudizio dopo la morte, quando per esempio non ci sarà più il tempo di “rimettere le cose a posto prima che gli altri se ne accorgano”, vuol dire parlare in modo più diretto e chiaro della verità che le azioni compiute hanno fatto in chi ascolta e che tutti (gli altri) vedranno. Attraverso la pubblicità, giacché il “giudizio” apocalittico è pubblico, la presenza degli altri e il fatto che loro vedono costringe ciascuno a tenere conto della verità piena di quel che sta facendo: per esempio un “tradimento pubblico” ha già di per sé una verità piena, che è la rottura di un rapporto (per esempio di amicizia, o di matrimonio, o di fiducia); proprio per questo chi tradisce di solito lo fa in privato, senza che la parte lesa sappia. Probabilmente in pubblico non lo farebbe. Detto in termini evangelici: «se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa...» (Lc 12,39). Ecco perché «il giorno del Signore verrà come un ladro di notte...», ma non per quelli che sono nella luce (1Ts 5,2-4).
Da questa prospettiva si vede quanto è importante tenere conto che il discorso sulla fine dei tempi è discorso da vivi a vivi. Dimenticarlo vuol dire trasformare il discorso in condanna inappellabile: se il tempo è finito (dato che contraddice l’esperienza di chi ascolta, che è vivo), non c’è più nulla da fare, la verità che siamo resterà immutabile, tombale. E poiché chiunque ascolta sa bene di non essere perfetto e di aver fatto qualche seppur piccolo errore nella propria vita, questa verità non potrà che suonare (falsamente) una disperante condanna.
L’essere dentro il tempo invece permette di cambiare in meglio quella verità profonda che le azioni hanno determinato dove negativa, e di apprezzarla a pieno ed iniziare a goderne dove invece è positiva. Ecco allora che parlare ai vivi di ciò che rivela la verità della persona, il giudizio e le sue conseguenze (inferno e paradiso), è quindi un grosso gesto di amore che chi parla compie nei confronti di chi ascolta. Questa verità profonda non è facile da cogliere, non sempre appare in superficie quando si è immersi nella vita ordinaria, distratti in tante voci e preoccupazioni, spesso diverse da quella di Dio e del bene, che parlano e coinvolgono. Prendere coscienza della verità che si sta costruendo, laddove questa è ancora aperta, regala la possibilità di aumentare il bene e di pentirsi dal male.
In un’ottica cristiana, che crede in un Dio che è amore e misericordia e si fa uomo per salvare l’uomo, questo discorso non si limita solo ad “avvertire” o a “informare”. Apre l’ingresso e la partecipazione alla divinità; condivide un mistero, che vince il male e dà una vita che ha vinto la stessa morte. Non è un caso che Signorelli, oltre che all’ingresso della cappella, si “autoritragga” anche fra i dannati, pur essendo vivo: il discorso è rivolto e intende coinvolgere i vivi, perché entrino nel mistero della misericordia di Dio, con tutte le conseguenze (di decisioni, di comportamento, di salvezza) che questa misericordia inspiegabilmente porta con sé.: «Il tempo (chronos) è un essere che mangia i suoi figli» dice un adagio classico: ogni azione che entra nel passato non è più disponibile, una volta “fatta” fa parte di noi e della nostra storia, irrimediabilmente. Se uno ha rubato, potrà sempre restituire, forse anche il doppio, ma, anche se il danno materiale è risarcito, chi ha rubato resta ladro; ladro che ha risarcito, ma pur sempre ladro. L’unica “forza” che può cambiare questo dato inesorabile sono l’amore e il perdono. Solo il perdono, che è ben diverso dal semplice accettare un risarcimento, può ridare a chi ha rubato la sua “innocenza”. Solo l’amore e la misericordia possono ricreare un’amicizia o un rapporto coniugale traditi. La misericordia, che si esprime nel perdono, ha la forza divina che solo il Creatore ha: c’è qualcosa di misterioso che unisce la potenza dell’amore alla potenza della vita, che è potenza della creazione, in forza della quale il tempo e la vita avanzano e non possono essere fermati. Certo l’amore umano, come il perdono umano, è debole; viene dato con difficoltà, può “tornare indietro” e rinfacciare, e non sempre l’uomo ne è capace. L’amore divino invece, come il perdono divino con cui entriamo in contatto nella liturgia, è saldo, irreversibile, eterno: non verrà mai meno (1Cor 13,8- 13). Perché atto d’amore di Dio, il giudizio divino è un giudizio il cui fine è portare l’uomo in paradiso. Parlarne è un modo, impegnativo, di aiutare l’uomo a lasciarsi prendere dal mistero dell’amore di Dio, che ha preso su di sé il male del mondo per salvare il mondo, incluse le persone che ascoltano il discorso sugli ultimi tempi e partecipano al culto, e al contatto con il mistero che esso celebra.
Daccapo, non si tratta d’informare, di una telecamera collocata alla fine del tempo per portare nel tempo quello che nel tempo non può entrare (neanche Gesù conosce il giorno e l’ora, ma solo il Padre: Mc 13,32; cfr Mt 24,36). La dottrina sui Novissimi, parte del Vangelo di Gesù Cristo Figlio di Dio, consegna e offre a chi vi entra in contatto la partecipazione a un mistero d’amore che salva e redime: “Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.” (Gv 3,17).
Dottrina dei Novissimi e liturgia nella cappella di San Brizio
Nel Quattrocento italiano i testi e le preghiere con cui si celebrava la messa erano in latino, già da tempo incomprensibile alla stragrande maggioranza del popolo cristiano, e il rituale prevedeva che una loro parte importante venisse letta a voce bassa. Nei primi secoli dell’era cristiana, alla nascita della Chiesa e della liturgia, il contenuto e la forma delle parole proclamate all’assemblea o rivolte a Dio nel culto erano comprensibili: chiedevano perciò la partecipazione piena e pienamente attiva dei partecipanti. Con il passare del tempo la lingua e lo svolgimento del rito, sempre meno comprensibili, resero questa partecipazione pienamente attiva via via più difficile, e meno legata ai contenuti del dialogo che nella celebrazione il prete intesseva con Dio a nome dell’assemblea stessa. La devozione popolare non si rassegnò tuttavia a questo depauperamento dell’accesso diretto dei contenuti letterali della liturgia, e trovò nei secoli modalità e forme nuove e “alternative” per entrare con i sensi nel mistero.
Già San Gregorio Magno, nel VI secolo, chiama Biblia pauperum (Bibbia dei poveri) le pitture degli edifici di culto, che spesso seguivano come programma iconografico l’esposizione delle storie bibliche. Trattandosi di edifici nei quali si celebrava la liturgia, il fine, come abbiamo visto per l’apocalittica, non era tanto o solo di consegnare informazioni, ma quello di aiutare l’orante a prendere contatto con il mistero celebrato. Anche nella cappella di San Brizio la successione dei temi scelti, attingendo alla teologia e alla dottrina che a partire dalla Bibbia era stata elaborate fino ad allora dai “maestri della Sacra Pagina”, ruota attorno all’altare, nel quale veniva celebrata l’Eucaristia.
Il Signorelli, coinvolgendo chi si ferma a contemplare i suoi affreschi con l’impatto forte e affettivo che le sue immagini trasmettono, ritorna a consegnare ai temi apocalittici la loro originaria vocazione. Il mistero, celebrato quasi tutto sottovoce e in latino, coinvolge l’assemblea orante non più attraverso i suoni e i gesti spesso incomprensibili di un prete fisicamente distante e separato, ma attraverso le immagini dipinte nelle pareti dell’edificio in cui la celebrazione avviene.
I riferimenti storici e dottrinali ai quali il Signorelli si dovette uniformare per ordine della committenza, vengono declinati e orchestrati in modo da coinvolgere la vita presente e contemporanea all’artista. Di fatto gli affreschi uniscono all’illustrazione della “dottrina” la polemica e l’esaltazione di persone, di stili di vita, di operazioni e gesta che facevano parte della cronaca e della quotidianità di chi “entrava” nello spazio affrescato per partecipare, pur distante, al culto che il prete officiava. In quest’ottica appare allora chiaro che la funzione delle immagini come Bibbia dei poveri, cara a S. Gregorio Magno come a San Giovanni Damasceno, non è soltanto spiegare il contenuto dei Libri Sacri a chi non sa leggere (o non capisce il latino) o non può disporre dei libri stessi, quanto soprattutto il coinvolgerli anche attraverso altri sensi (non solo l’udito, ma anche la vista e il corpo attraverso la spazialità del tempio) nel mistero che è loro rivelato e così consegnato. La ricca tradizione anche umanistica, nella quale Signorelli s’immerge e alla quale attinge, determina sia l’impianto figurativo sia le modalità, i soggetti, i temi, le posture e le azioni che egli dipinge. In questo modo spinge avanti non solo la tecnica pittorica e l’antropologia e la conoscenza del corpo umano, ma anche la concreta interpretazione e lettura degli eventi apocalittici per condividere il mistero di salvezza che essi vogliono servire e condividere. In questo modo tutto è “orchestrato” a coinvolgere, a trasmettere al fruitore dell’opera d’arte il mistero (biblico) che essa consegna insieme alla liturgia. Il fine è, attraverso questo coinvolgimento, trasformare la vita del credente nel suo agire, nei suoi modi di pensare e di porsi davanti al suo prossimo.
I “colori” e le tinte di questo coinvolgimento trasformante sono nei nostri affreschi particolarmente evidenti. La concretezza della corporeità che risorge, la connessione fra disperazione e inferno, la ripugnanza del demonio e dell’oscurità contrapposta alla luce e alla gioia dorata di Dio, la crudeltà dell’oppressione sconfitta e la bellezza dell’amore che innalza e fa rivivere... tutto ciò, ed altro ancora, rivela il modo di vivere e la fede di Signorelli, dei circoli e degli ambienti ai quali attinge e delle filosofie che gli consegnano la tradizione e che egli sposa. Questo modo di vivere la vita e la fede fa da mediazione fra il testo biblico, all’origine della dottrina alla quale Signorelli si attiene, e le persone che entrano nello spazio del culto per accedere al mistero che in esso si fa sensibile.
Attorno all’altare
Paradiso e inferno, nei due quadri contrapposti (e nel cui centro stanno non a caso l’altare e il prete celebrante, sovrastato dal Cristo giudicante) sfidano (o meglio inducono) colui che li guarda a “prendere posizione”. Un esempio fra i tanti è il dettaglio del demone (o del Signorelli stesso) che artiglia la formosa fanciulla: è un chiaro rinvio che qualifica desideri ben noti anche ai fruitori, la cui collocazione fra i dannati attiva quel dinamismo di distanza dall’egoismo e di “conversione” che vuol portare dall’inferno e dalla forse dolciastra ma triste disperazione alla gioia e alla felicità del paradiso.
L’opera d’arte del Signorelli esercita sul suo fruitore una presa provocatoria, che si serve di un registro af- fettivo ben diverso rispetto a quello che impiega il Beato Angelico nell’affresco del Cristo giudice sulla volta. Eppure paradossalmente questa presa, attorniando l’altare e il mistero che vi veniva celebrato, in- staura una complicità con il sacramento che può forse spiegare la vena artistica che porterà il Signorelli a dedicarsi a tante opere di devozione popolare.
In un periodo storico le cui élites culturali spesso frequentavano e riscoprivano il neoplatonismo e il suo linguaggio raffinato ed esclusivo, il Signorelli, muovendo da una fisicità in movimento e carnale come quella che i tanti nudi espongono in questi affreschi, preferisce a una contemplazione intellettuale il suo particolare “gioco di squadra”, forte (a tratti provocatorio), con i fruitori dei suoi affreschi. Queste sue opere instaurano con il pubblico un’interazione, ruotante attorno all’altare e al mistero che lì si celebra, che gli permetterà di trovare e offrire senso a quella devozione popolare, che tanta parte occuperà delle sue opere successive. All’intellettuale e inevitabilmente elitaria illustrazione della salvezza cristiana espressa in linguaggio platonico, Signorelli, con fine intuito, qui mostra di preferire e dipingere una carnalità in movimento e in tensione, per trasportare con essa i suoi destinatari dentro il mistero di eternità, che la misericordia divina consegna e di- spensa a chi le si affida e che il sacrificio dell’altare celebra.
Al servizio di una partecipazione più piena, dentro un coro di Tradizione
La storia della liturgia medievale rivela un’attenzione crescente alla visibilità e all’effetto coinvolgente dei gesti liturgici, con il fine di suscitare l’affetto verso Dio e la devozione. Facendo propria questa attenzione, l’architettura e la decorazione dei luoghi di culto rispondevano a un bisogno delle persone che partecipa- vano al culto stesso. Signorelli si inserisce allora in questa corrente, che parte da molto prima del Quattrocento. Mette a disposizione di questo “coinvolgimento nei misteri” del Vangelo celebrati nel culto la sua raffinata tecnica artistica, ma anche la sua vivace e estrosa capacità di accogliere, elaborare o assimilare le istanze del prossimo, incluse le tecniche artistiche altrui.
Si è parlato, con una certa ragione, di “teatralità” a proposito della sua opera nella cappella di S. Brizio. L’ampiezza del movimento delle masse, la loro articolazione, le provocazioni dei nudi, le allusioni alla storia recente...tutto è “arruolato” a “fare presa” sulla persona che partecipa al culto per essergli di aiuto al contatto sensibile con il mistero che veniva celebrato sull’altare. L’obiettivo, ambizioso, è quello di servire la trasformazione integrale della vita del partecipante, ben oltre il breve momento della liturgia. La permanenza visibile degli affreschi, in questo modo, evocava ed evoca permanentemente quella trasformazione, che attraverso la partecipazione al culto, premeva per entrare ed essere presente, come luce e sostegno, nella vita ordinaria, liturgica ed extraliturgica. I gesti e le preghiere del culto erano ormai assai deboli nel far “presa diretta” con la loro letteralità sugli affetti e sulla mente dell’assemblea in preghiera, servivano questa trasformazione solo con l’assistenza (“assistere alla messa” si diceva fino a non molto tempo fà) dei presenti, a parte forse il prete. Ecco allora che l’artista si mette al servizio del coinvolgimento “sensibile” degli oranti con gli affreschi che attorniano l’altare e l’assemblea che ad esso si presenta.
Ed allora cosa più che le immagini forti del linguaggio apocalittico potevano “fare alleanza” con l’artista in questo comune servizio, cultuale e pittorico? Con felice intuizione, non priva in Italia di una buona originalità, la committenza, chiede per tutte le pareti della cappella la pittura dei Novissimi e trova in Si- gnorelli un’esperta controparte. L’ascolto dei “maestri della Sacra pagina”, che il contratto ancora esistente attesta, aiutò l’artista ad entrare nell’alveo della tradizione sia della Bibbia sia della dottrina e dell’elaborazione che del dato biblico la Chiesa aveva fatto fino al Quattrocento. In tal modo con la ricchezza della tecnica pittorica, sua propria ma anche quella assimilata da altri (non è difficile vedere diverse citazioni di altre opere), egli si aggiunge come nuova voce al ricco coro di agiografi, scrittori di testi apocalittici, teologi, artisti, semplici fedeli che nel corso dei secoli hanno trasmesso e servono l’accesso al mistero di chi prega.
Il risultato è quanto abbiamo sotto gli occhi e quanto oggi possiamo godere: una raffinata orchestrazione di spazi, luci ed immagini di un luogo di culto, il cui fine principale è portare lo “spettatore” che preghi in contatto con l’identità profonda della propria persona, qual è rivelata e costruita dalle sue opere, per poterla lasciar illuminare dalla luce solare della misericordia di Dio. Gli affreschi di questa cappella vogliono essere allora una finestra sempre aperta sugli “ultimi tempi”, dai quali entra un raggio di luce che fa verità della vita “in cammino” di chi li guarda. Questa ferma permanenza di apertura luminosa si sposa con la vivente e dinamica ripetizione del culto che in mezzo ad essi si celebra ogni settimana o ogni giorno. La liturgia e la preghiera infatti sono modo eminente di entrare e vivere il contatto con quello stesso mistero la cui luce s’irradia dalla finestra che sono gli affreschi. A partire dalla partecipazione e dal contatto celebrato con questo mistero, la vita e le opere dell’uomo possono di nuovo immergersi nella misericordia salvante di Dio, correggersi ed emendarsi lì dove il male ha fatto breccia. Possono così prendere distanza, ogni volta maggiore e rinnovata, dall’angoscia e dalla tristezza del male ed avvicinarsi sempre di più alla luce e all’oro gioioso del cielo e del paradiso, anche in mezzo all’assedio dell’Anticristo.
La festa dei colori e la certezza delle fede, celebrata nel culto e condivisa con Signorelli e con gli altri cristiani nel corso della storia, si fa offerta, a ciascun fruitore, di sensibile partecipazione comune a quella gloria eterna, che il paradiso e il discorso su di esso intende far scoprire in qualche modo già presente nel bene che pure c’è in mezzo a noi, anche se in crescita verso una pienezza, come tutte le cose di ogni vita che pulsi d’amore.